Il giovane biologo di Carpegna e la scoperta su Leonardo da Vinci, "apripista" della bioarchitettura
Il biologo Andrea da Montefeltro nell'equipe che ha studiato il Codice Madrid II del Da Vinci: la scoperta sulla carbonizzazione del legno

Nel cuore del Rinascimento, tra le dense pagine del Codice Madrid II, Leonardo da Vinci annotò sul foglio 87r: “Saranno meglio conservate se scortecciate e bruciate in superficie che in ogni altro modo”. Questa frase, appena visibile, descrive la carbonizzazione superficiale del legno, scoprendo un metodo che oggi è al centro della bioarchitettura sostenibile. Il Codice Madrid II, custodito alla Biblioteca Nazionale di Spagna, è uno dei manoscritti più tecnici e meno noti di Leonardo, ricco di studi su meccanica, ingegneria, architettura e scienza dei materiali. Qui la nota sulla bruciatura superficiale emerge come l’esito di un pensiero sistemico, capace di integrare osservazione empirica, saperi antichi e visione futuristica.
La riscoperta di questa intuizione è merito di tre studiosi italiani di rilievo internazionale: Annalisa Di Maria, autorità mondiale su Leonardo da Vinci e membro del Club Unesco di Firenze. Andrea da Montefeltro, originario di Carpegna, biologo molecolare e scultore, specialista in analisi comparata scientifica e figurativa. Lucica Bianchi, storica dell’arte ed esperta in ricerca documentaria.
Oggi sappiamo che la carbonizzazione superficiale produce tre effetti fondamentali: impermeabilizzazione, il calore sigilla i pori del legno, impedendo l’assorbimento di acqua; resistenza al fuoco: lo strato carbonizzato agisce da isolante, rallentando la combustione: protezione biologica: la perdita di nutrienti rende il materiale inospitale per insetti e funghi.
Leonardo teorizzò questa tecnica in un’epoca in cui la conservazione del legno si basava su metodi passivi, come l’immersione subacquea dei pali veneziani. La sua intuizione anticipa di secoli i moderni protocolli di bioarchitettura, incentrati su durabilità e basso impatto ambientale. Instancabile lettore, Leonardo lesse Plinio il Vecchio (Naturalis Historia), Vitruvio (De Architectura) e Palladio, ma la carbonizzazione superficiale è un suo originale contributo, non rintracciabile in alcuno di questi testi. Gli studiosi escludono influenze esterne su questa scoperta, sottolineando la coerenza interna del Codice Madrid II. Leonardo non si limitava ad accogliere il sapere: lo interrogava, lo sperimentava e lo rideclinava in chiave pratica.
Nel Codice Madrid II sono illustrate anche: scelta delle specie, rovere e castagno per la resistenza, frassino e tiglio per la flessibilità, ontano e salice per usi subacquei; stagionatura naturale: lasciando i tronchi “sopra le radici” per il naturale deflusso della linfa; applicazioni architettoniche: castagno e faggio per rinforzi strutturali; uso musicale: acero e tiglio per strumenti, dove la qualità del suono dipende dalla fibra e dalla maturazione.
Oggi architetti e designer impiegano la carbonizzazione superficiale per rivestimenti ecologici, facciate ventilate, arredi urbani e soluzioni tailor-made che riducono la CO₂. L’interesse di università e centri di ricerca in scienza dei materiali conferma il potenziale tecnico di un’idea nata oltre 500 anni fa. La riscoperta di questa annotazione non è una mera curiosità storica, ma una lezione di sostenibilità e innovazione. Mostra come Leonardo – radicato nel passato e proiettato nel futuro – continui a suggerirci che la crescita responsabile nasce anche dalla riscoperta delle nostre origini.
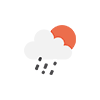 12.1°
12.1°



