Un salto che ha ispirato il genio: la cascata che ha un legame con Dante e che nessuno conosce
La Cascata dell’Acquacheta, in Emilia Romagna, il salto da 70 m che ispirò Dante. Natura selvaggia, trekking e curiosità nascoste.

La Cascata dell’Acquacheta è una delle meraviglie più suggestive dell’Appennino Tosco-Romagnolo, immersa nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tra Emilia Romagna e Toscana, nel territorio di San Benedetto in Alpe (FC). Il torrente Acquacheta nasce sul crinale appenninico e, dopo un percorso tra boschi fitti e forre selvagge, precipita per oltre 70 metri in un salto fragoroso, creando uno spettacolo scenografico che colpisce per la sua imponenza e armonia. Questa cascata, incastonata in un contesto naturale ancora integro, è uno dei luoghi più celebri citati da Dante Alighieri nella Divina Commedia, precisamente nel XVI canto dell’Inferno, a testimonianza del suo valore simbolico e letterario.
Il percorso per raggiungerla è uno dei più frequentati del versante romagnolo del Parco: parte dal borgo di San Benedetto in Alpe, antica località monastica, e segue un sentiero escursionistico di circa 4 km (andata), con un dislivello moderato di circa 240 metri, adatto anche a famiglie e camminatori occasionali. L’escursione attraversa ambienti forestali di rara bellezza, popolati da faggi, carpini neri, tigli selvatici e abeti, alternando radure panoramiche a ombrosi boschi secolari. Il cammino è punteggiato da resti storici e architetture rurali, come antichi mulini in pietra e ponticelli ad arco, che contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa nel tempo.
Un salto al confine tra natura e letteratura
Quello dell’Acquacheta non è un salto qualsiasi: la sua fama è legata al verso immortale di Dante Alighieri, che utilizzò il fragore della cascata come paragone sonoro al fiume infernale Flegetonte, nel passaggio che introduce il terzo girone dell’Inferno:
“Come quel fiume, c’ha proprio cammino
primo dal Monte Veso inver levante,
da la sinistra costa d’Appennino,
che si chiama Acquacheta suso,
***avanti che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è disuso,
rimbomba là sovra San Benedetto
dell’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser ricetto…”
(Inferno, XVI, 94–102)
Il nome “Acquacheta”, secondo alcuni studiosi, deriverebbe dal carattere “cheto”, cioè tranquillo, del torrente nel suo tratto iniziale, prima della caduta impetuosa. Il salto è formato da una parete di arenaria stratificata, che si sviluppa in larghezza per decine di metri, creando un velo d’acqua continuo e potente. Alla base si trova la cosiddetta Piana dei Romiti, un’ampia radura un tempo abitata da comunità monastiche eremite, oggi punto di sosta per escursionisti.
Questo tratto di Appennino rappresenta un vero e proprio “paesaggio letterario”, dove la natura incontaminata si intreccia alla memoria storica e culturale della Divina Commedia, creando un legame unico tra la dimensione fisica e quella poetica.
Trekking, fauna e curiosità storico-ambientali
Il percorso escursionistico più frequentato per raggiungere la cascata è il Sentiero CAI 407, che in circa 1 ora e 30 minuti di cammino conduce fino al salto. Il tracciato è ben segnalato, e lungo il percorso si attraversano punti panoramici affacciati sulle gole e alcuni interessanti edifici storici, tra cui l’antico Mulino dei Romiti, in pietra, simbolo dell’attività rurale del passato. Per i camminatori più esperti, esistono anche itinerari alternativi, più lunghi e impegnativi, che passano per il Passo della Peschiera, il Monte Lavane o la valle del Fosso dei Campacci, con dislivelli superiori ai 700 metri.
L’ambiente circostante è ricco di biodiversità: nei pressi della cascata si possono osservare anfibi rari come la salamandra pezzata, libellule alpine, farfalle diurne e pesci autoctoni come la trota fario. Il territorio è parte di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), riconosciuta a livello europeo per la tutela di habitat prioritari e specie faunistiche protette.
La cascata è attiva tutto l’anno, ma il periodo ideale per visitarla è la primavera, quando la portata del torrente raggiunge il massimo grazie allo scioglimento delle nevi e alle piogge. In estate, invece, il getto si riduce notevolmente, ma l’ambiente si arricchisce di ombre e silenzi, regalando un’esperienza altrettanto magica.
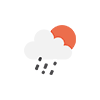 10.5°
10.5°



